|
|
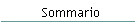 |
|
di Christina Niederstein |
|
|
(deutsche
Übersetzung) |
|
"Per poter veramente affrontare
la "malattia", dovremmo poterla incontrare fuori dalle
istituzioni, intendendo con ciò non soltanto fuori dall'istituzione
psichiatrica, ma fuori da ogni altra istituzione la cui funzione è
quella di etichettare, codificare e fissare in ruoli congelati coloro
che vi appartengono. Ma esiste veramente un fuori sul quale e dal quale
si possa agire prima che le istituzioni ci distruggano?" (Franco
Basaglia). |
|
|
|
(in "Il problema della gestione",
1968) |
|
|
|
Il 13 maggio1978 viene approvata dal
Parlamento italiano la legge 180 Basagliana che riforma l'assistenza
psichiatrica. "La miseria dei nostri pazienti e parte della miseria
del mondo. Quando diciamo no al manicomio diciamo no alla miseria del
mondo" (Franco Basaglia). |
|
|
|
Basaglia dice, che "una realtà
drammatica ed oppressiva, come quella del manicomio, non può dunque
attuarsi senza una violenza polemica nei confronti di ciò che si vuole
negare, coinvolgendo nella critica i valori che consentono e perpetuano
l'esistenza di una tale realtà, questo, il discorso nostro
anti-istituzionale, antipsichiatrico (cioè anti-specialistico) non può
mantenersi ristretto al terreno specifico del nostro campo d'azione. La
polemica al sistema istituzionale esce dalla sfera psichiatrica per
trasferirsi alle strutture sociali che lo sostengono, costringendoci ad
una critica della neutralità scientifica, che agisce a sostegno dei
valori dominanti, per diventare critica e azione politica. Ogni indagine
scientifica sulla malattia mentale è in se possibile solo dopo aver
eliminato tutte le sovrastrutture che rimandano dalla violenza
dell'istituto, alla violenza della famiglia, e alle violenze della
società e di tutte le sue istituzioni." |
|
La situazione del malato è che si è
ammalato in società. A quel punto si deve considerare la
"invivibilità" di questa società per un uomo. Il suo essere
ammalato si scontra con la violenza che arriva da parte della società,
per paura e odio per la malattia che significa diversità (e è per
quello che la società lo espelle), perché il malato mette in pericolo
il ruolo che la difende, e perché ha poi bisogno di un'area di compenso
per la miseria di ogni singolo dei suoi elementi, che poi giustifica
l'ideologia di vita nel benessere a-contraddittorio. Una realtà che la
società rifiuta di vedere ma che poi risulta la realtà intorno alla
quale si costruisce la vita dei suoi membri "sani". Poi il
malato viene escluso della società e si trova di fronte a un'altra
violenza, questa volta quella dell'istituto. Contro queste premesse,
aiutare veramente il malato, e curarlo, vuol dire renderlo capace di
trovarsi di nuovo di fronte a questa società, ma questa volta con un
volto diverso. Dovrà essere in grado di dialetticizzare la società, di
analizzare e comprendere il funzionamento del sistema, per cosi
resistere a questo nel suo produrre ruoli oggettivanti. Per così
rimanere persona vivendo un rapporto reale e vero con questo mondo
"sano", perché sono diventati trasparenti i meccanismi di
potere e di violenza, libero, perché può adesso incontrare questa
realtà senza essere divorato dall'odio e senza la perdita del sé.
Perché ora è uomo con una storia ed una esperienza che è riuscito a
smascherare l'ideologia del potere e ritrovare il suo posto vivendo le
contraddizioni della realtà, e affrontando questa con la sua volontà. |
|
"L'unica possibilità," dice
Basaglia, "che ci resta è di conservare il legame del malato con
la sua storia, che è sempre storia di sopraffazioni e di violenze,
mantenendo chiaro da dove provenga la sopraffazione e la violenza. Per
questo rifiutiamo di proporre la comunità terapeutica come un modello
istituzionale che verrebbe vissuto come la proposta di una nuova tecnica
risolutrice di conflitti. Il senso del nostro lavoro non può che
continuare a muoversi in una dimensione negativa che è, in se,
distruzione e insieme superamento. Distruzione e superamento che vadano
oltre il sistema coercitivo-carcerario delle istituzione psichiatriche,
quello ideologico della psichiatria in quanto scienza, per entrare nel
terreno della violenza e dell'esclusione del sistema socio-politico,
rifiutando di farsi strumentalizzare da ciò che si vuole negare." |
|
|
|
L'istituzione psichiatrica e il
discorso sulla follia rappresentano il potere che esprime il
funzionamento del suo ruolo, come questo si manifesta e come si
perpetua. Nelle istituzioni il potere esclude gli elementi della
società che non lo hanno. Questa situazione esige il ruolo. Il ruolo
della persona o dell'istituzione che ha il potere, e quello
dell'elemento (o gruppo) della società nostra che non lo ha, e che per
questo è senza dritto di essere uomo, e senza il dritto di esprimersi.
Basaglia dice che "le istituzioni psichiatriche sono
strutturalmente impenetrabili ad ogni tipo d'intervento che vada oltre
la loro finalità custodialistica e che se questo non fosse cosi, il
carattere intrigrante dell'atto terapeutico sarebbe evidente." La
finalità custodialistica è la netta conseguenza dell'esclusione di
certi membri di disturbo per la società. L'ideologia scientifica,
religiosa, custodialistica, pedagogica, nasconde la realtà
istituzionale. A ben esaminarla, Basaglia dice, "la malattia, come
condizione comune, viene ad assumere un significato concretamente
diverso, a secondo del livello sociale di chi è malato, e che è il
sistema socio-economico che determina le modalità a livello
diverso." A quel punto è ovvio che è stata la società ad
escludere gli elementi che il sistema non ha integrato, perché sono i
più deboli, i più poveri, i più svantaggiati. Essi sono una minaccia
per il sistema perché rappresentano la parte scura di sofferenze che
derivano dalla società capitalista-produttivistica, che deve essere
nascosta per il buon funzionamento del sistema di oppressione e di
sottomissione attuato dal potere. Basaglia dice, che "qui si
evidenzia come non sia tanto in gioco la malattia, quanto la mancanza di
valore contrattuale di un malato. Il manicomio ha risposto ad
un'esigenza della società nell'espellere gli elementi di
disturbo." La psichiatria ha confermato scientificamente la
correttezza dell'espulsione. Basaglia ha analizzato questa dimensione
istituzionale, dove la reciprocità non esiste, perché una condizione
di privilegio non permette la reciprocità dell'incontro. Un incontro
dove si nasconde la realtà sociale di esclusione e di violenza, che
invece dovrebbe essere "l'humus" sul quale appoggiare il
rapporto terapeutico, non nascondendosi dietro ideologie antisociali che
hanno come obbiettivo l'annullamento della persona del malato. Il
disturbo del malato a quel punto e gia alienato dalla sua realtà
personale e dalla realtà della vita intorno a lui. Tutto questo succede
nell'interno di una struttura asilare che non ha più a che fare con la
vita vera perché la sua funzione è l'isolamento del malato dalla vita,
con una conseguenza distruttiva per il suo se. Poi condannato per il
male che rappresenta e il dolore che causa. |
|
Basaglia dice che "lo psichiatra
si difende dal malato mentale e dalla sua malattia e impone il suo
giudizio di valore. Lo psichiatra non capisce le contraddizioni della
nostra realtà e allora non resta altro che scaricare l'aggressività
accumulata sull’oggetto provocatorio che non si lascia comprendere.
Qui si vede cos’è che la scienza psichiatrica, come espressione della
società che la delega, ha voluto fare del malato mentale, in un sistema
dove ogni rapporto è rigidamente determinato da leggi economiche. Il
problema non è quello della malattia in sé ma soltanto di quale tipo
sia il rapporto che viene ad instaurarsi con il malato. Lo psichiatra
mette in atto l'esclusione (che la società ha gia messo in atto) verso
colui che non si è integrato nel gioco del sistema. La norma non è un
concetto elastico e discutibile ma qualcosa di fisso e di strettamente
legato ai valori del medico e della società di cui è il
rappresentante. Si può osservare la tentazione di sedare velocemente
l'ansia dello psichiatra che questo rapporto reale con il malato gli
provoca costantemente, avendo in mano gli strumenti per difendersi del
malato e della problematicità della sua presenza. L'invenzione del
malato a somiglianza dei parametri in cui lo ha definito la
scienza." |
|
La psichiatria nega istituzionalmente
al malato mentale il suo dritto di essere uomo cosi non permettendogli
"un corpo con la possibilità di ricostruirsi un corpo proprio che
riesca a dialettizare il mondo." (Basaglia). |
|
Trattato come uomo, il malato mentale
non rappresenta più una malattia ma una crisi, non compresa dalla
situazione istituzionalizzata, che non accetta la soggettività del uomo
e che non rispetta la sua integrità. Con la comprensione della crisi il
malato mentale non rappresenta più una malattia isolata e assoluta, ma
un uomo che rappresenta un mondo sano, un corpo con difficoltà a
dialettizzare il mondo, perché è stato rifiutato e sottomesso,
diventando oggetto sul quale la scienza ha applicato la sua regola. Un
destino al quale non è stato permesso di spiegarsi il mondo, una
situazione che in se è fonte di malattia e di perdita di libertà e di
vita. |
|
Basaglia accetta la condizione di
parità tra medico e paziente. Invece, il rapporto dello psichiatra
tradizionale col paziente è l'incontro tra il medico che agisce nel
nome dell’ideologia scientifica, e il paziente che è sotto controllo
(un controllo sociale). Una situazione questa che non permette al malato
di ricuperare la sua soggettività, ma che ne determina l'adattamento
pacifico alla situazione generale del sistema, per togliergli il suo
carattere critico che ha di fronte alla società. |
|
Questa situazione è origine di una
condizione di malattia, perché determina regressione. Malattia causata
dal potere oppressivo e dall'annientamento della persona del malato. Lo
psichiatra cosi controlla tecnicamente le reazioni nei suoi confronti,
nel suo ruolo di escludente. |
|
"L'autorità solo può causare
simili danni: l'annientamento del malato. Nel rapporto o si sceglie la
libertà dell'uomo (e quindi la resistenza che può opporgli) o il
"buon andamento del ricovero", dice Basaglia. Nel primo caso
l'ideologia che giustifica la posizione sociale dell'istituto è
smascherata di fronte alla realtà del funzionamento del potere, e delle
contraddizioni sociali che si nascondano dietro il giudizio
discriminante di fronte a gli elementi esclusi della società. Questo
smascheramento dell'ideologia si introdurrebbe automaticamente nel
discorso tra le parti, perché il malato introduce nel rapporto elementi
che servono a far entrare la realtà della situazione dell'esclusione,
della violenza dell’istituto e della violenza che ha subito in
società. A questo punto il rapporto tra malato e medico cambia, perché
si comincia a vedere l'istituzione da dentro, per quello che veramente
è e su che situazione si basa la sua permanenza in potere. |
|
"Il malato entra in manicomio
come persona per diventare una cosa. Noi siamo qui per dimenticare che
siamo psichiatri, per ricordare che siamo persone."(Franco
Basaglia) |
|
Dopo quasi trent'anni dalla legge
Basaglia, il discorso sui rapporti umani dove c'è l'amore, la
comprensione e l'uguaglianza, creativo perché c'è coscienza, non si è
realizzato: Cosa fa l'oggettivazione con gli uomini si vede rendendosi
conto della situazione in cui vivono gli immigrati, i tossici, i
senzatetto, gli emarginati. A favore del potere, (dell'etichettamento,
del pregiudizio discriminante, dell’esclusione), i tecnici e la
società offrono risposte che servono a loro stessi ma non ai malati o
gli altri esclusi. Non permettono una libera espressione di
soggettività. Ciò significa, dice Basaglia, "che è il medico ad
aver bisogno di un'oggettività su cui poter affermare la propria
soggettività; così com'è la nostra società ad aver bisogno di aree
di scarico e di compenso dove poter relegare e nascondere le proprie
contraddizioni." |
|
Basaglia dice "che lo psichiatra,
la scienza, la società si sono praticamente difesi dal malato mentale e
dal problema della sua presenza fra di noi: ma nella misura in cui, di
fronte ad un malato già violentato dalla famiglia, dal luogo di lavoro,
dal bisogno noi eravamo i detentori del potere, la nostra difesa si è
inevitabilmente tramutata in una offesa senza misura, aumentando la
violenza che abbiamo continuato ad usare nei confronti del malato sotto
il velo ipocrita della necessità e delle terapie." La società,
difendendosi da ciò che fa paura, ha sempre imposto alle organizzazioni
delegate a curare i malati mentali quel sistema di norme, limiti e
ruoli, al di fuori del quale non permette nessuna esistenza. |
|
L'esclusione è la conseguenza di vita
non vissuta, di sofferenze non calmate, perché non era possibile vivere
in una società di tali restrizioni e di tale violenza, che soffoca
l'individualità e distrugge libertà, sotto la dottrina del sistema
capitalista della classe dominante. |
|
Basaglia dice che l'intersoggetività
nei rapporti tra medico e paziente richiede che il terapeuta sia libero
di ogni pregiudizio o qualunque risposta preformata nell'incontro con la
persona, per evitare l'ettichettamento e l'oggettivazione. Per non
permettere spazio per il ruolo nel rapporto, il ruolo che difende
dall'incontro, il potere stigmatizzante. Il rispetto per il disagio
psicologico della persona (la diagnosi non esprime il valore della
sofferenza della persona) e la libera espressione del malato è in
contrasto con la diagnosi scientifica e le statistiche. Secondo Basaglia
la conoscenza delle circostanze particolari di vita della persona,
quelle sociali, familiari, lavorative, è importante per il medico,
perché serve a conoscere la persona con cui si entra in contatto, per
evitare che si crei un rapporto astratto, diagnostico col malato, per
arrivare alla conoscenza contestualizzata di una persona con difficoltà
esterne. |
|
|
|
L'incontro tra medico, staff e
paziente potrà essere un incontro che apre porte nuove, di comprensione
e di conoscenze, di possibilità di rapporti, di possibilità di vivere
una situazione comune, di uguaglianza, interscambio, accettazione e
rispetto. Sempre le esperienze di sofferenze dei malati, la loro
esperienza personale con la vita in questa società "invivibile",
il loro essere esclusi perché non hanno retto al gioco del sistema,
possono rappresentare elementi chiave d’interscambio di questo
incontro, che include il rapporto naturale loro col mondo esterno, la
società. Questo dà un senso al quel periodo di presenza nel ospedale
che dividono. Perché una volta che questa realtà diventa trasparente
per i malati, loro possono avere una storia, vivere in contatto con la
realtà. Un contatto che la società non vive, essendo cieca alle sue
contraddizioni e solo la loro percezione può impedire l'espansione di
ideologie del potere. Spesso i malati si cronicizzato perché la situazione
nell'istituto non ha nessun valore terapeutico. La situazione di
depersonalizzazione (nell'incontro manca il secondo polo, quello del
malato) e di decontestualizzazione (l'ideologia scientifica nasconde la
realtà al malato facendogli credere che lui ha una malattia "non
umana" e non razionale, finché il malato perde finalmente il
rapporto con se stesso) del manicomio hanno come conseguenza una
distruzione del se del malato, che non gli permette di rapportarsi à se
stesso e al mondo intorno. |
|
Basaglia domanda un rapporto libero da
ogni predominio dell'uno sull'altro. Karl Marx dice: "Artista è
chiunque esce dal proprio cerchio e reinventa il suo ruolo nel rapporto
con gli altri". Pure vorrei riferirmi a questo punto a Foucault,
con cui Basaglia si interroga sulla malattia e sulla convivenza con
" la ragione buona" degli altri, dove il malato è parte della
verità e la verità parte di lui, prima che sia inglobato nel manicomio
con la diagnosi di malattia mentale. Basaglia vede, che "il
pensiero fenomenologico nonostante la sua disperata ricerca della
soggetività del uomo, non è riuscito a toglierlo dal terreno dell'oggetivazione
in cui si trova gettato." |
|
Franca Basaglia, la moglie di Franco
Basaglia, dice, "accettare il conflitto che ogni soggetto produce,
senza difendersi dietro schemi interpretativi ormai dogmi, e che,
accettando il rischio della libertà del malato diventa possibile
reggere la sofferenza, accettarne ogni espressione, per spostare il
conflitto ad un livello diverso. (Se il conflitto scompare, è sempre il
più debole a soccombere). Restano sofferenza, disagi, inadeguatezze ma
con un aspetto umano. Lei spiega, che nell'accettazione del altro e nel
conflitto che ne deriva c'è sempre il rischio di una perdita di sé
quando il ruolo non ti difende, non ti ripara. Ma è questa uscita del
ruolo che consente di passare ad un livello più alto, più
comprensibile, più divisibile per entrambi i poli. L'operazione di
smantellamento di mura reali e metaforiche, di grate e rigide
codificazioni, ha infatti richiesto il rispetto dei dritti della persona
sana e malata, e un confronto della propria disciplina con questi
diritti: il che alla sua volta esige la capacità di reggere il
conflitto che questo incontro produce, senza cancellarlo." |
|
Se ci domandiamo quali sono le cose
che pensa e sente il malato che ancora noi non abbiamo conosciuto, si
potrà aprire un altro, unico, rapporto con lui senza usare diagnosi
generalizzanti, tradizionali, prestabilite, ormai gia diventate dogmi.
Per liberare il contatto dal pregiudizio, dal privilegio e dalla
classificazione. |
|
La sottomissione e l'annientamento
della persona, esercitata dall'istituzione psichiatrica sulle sue
vittime, fa perdere al malato la sua libertà definitivamente. Mentre la
malattia già lo mette in condizione di insicurezza, sotto la condizione
di "vita" del manicomio, la perde completamente. Perde la
libertà e dignità perché non gli è permesso di essere uomo. Ogni
protesta da parte del malato per quanto riguarda il suo rapporto con
l'istituzione è presa come espressione della sua malattia.
L'istituzione sottomettendo mantiene l'individuo in condizione da non
permettergli di avere coscienza di quello che è la realtà manicomiale. |
|
Basaglia spiega, che, "se l'atto
terapeutico coincide con l'impedimento a che la presa di coscienza da
parte del malato del suo essere escluso si muove dalla sua particolare
sfera persecutoria (la famiglia, che convoglia sul più debole
l'aggressività accumulata dalle frustrazione di tutti, i vicini,
l'ospedale) per entrare in una situazione globale (presa di coscienza di
essere escluso da una società che realmente non lo vuole), non ci resta
che rifiutare l'atto terapeutico qualora tenda solo a mitigare le
reazioni dell'escluso nei confronto del suo escludente." Basaglia spiega
che "il nuovo psichiatra sociale, lo psicoterapeuta, l'assistente
sociale, lo psicologo di fabbrica, il sociologo industriale etc., non
sono che i nuovi amministratori della violenza del potere, nella misura
in cui, ammorbidendo gli attriti, sciogliendo le resistenze, risolvendo
i conflitti provocati dalle sue istituzioni, non fanno che consentire,
con la loro azione tecnica, apparentemente riparatrice e non violenta,
il perpetuarsi della violenza globale. Il loro compito, che viene
definito terapeutico-orientativo, è quello di adattare gli individui ad
accettare la loro condizione di "oggetti di violenza", dando
per scontato che l'essere oggetto di violenza sia l'unica realtà loro
concessa, al di là delle diverse modalità di adattamento che potranno
adottare." |
|
A questo punto tutti noi non abbiamo
più nessuna voce fuori di quello che il sistema permette. L'uomo è
sottomesso dal potere e così garantisce la permanenza di quel potere
perché non si ribella, non comprende che quello che gli viene detto, è
detto per escludere resistenza, per impedire che il funzionamento del
sistema diventi trasparente, per nascondere la realtà del funzionamento
del potere. Se cerca di impedire che si introducono cambi sociali e cosi
la violenza del potere si perpetua globalmente. Se accetta il suo ruolo,
quello che il sistema gli impone, e perde ogni possibilità di un
pensiero e di un comportamento che non risponde alle esigenze del
sistema, diventa schiavo del sistema che vuole e deve, per garantire la
sua permanenza, eliminare ogni comportamento personale, ogni espressione
individuale che si esprima fuori delle sue leggi. Basaglia rifiuta
l'atto terapeutico come risolutivo di conflitti sociali, che non possono
essere superati attraverso l'adattamento di chi li subisce. |
|
Basaglia dice, che "per
riabilitare l'istituzionalizzato, che vegeta nei nostri asili, sarà
più importante sforzarci di risvegliare in lui un sentimento di
opposizione al potere che lo ha finora determinato ed
istituzionalizzato. Dal risveglio di questo sentimento, il vuoto
emozionale in cui il malato ha vissuto per anni, tornerà a riempirsi
delle forze personali di reazione, di conflitto, dell'aggressività
sulla quale, sola, sarà possibile far leva per la sua riabilitazione.
Poi l'aggressività personale si risolverà in un azione di aperta
contestazione con il reale che il malato ora rifiuta, non più come atto
di malattia, ma perché si tratta veramente di una realtà che non può
essere vissuta da un uomo." |
|
|
|
Lo psichiatra controlla il malato sul
criterio dei valori della norma, valori che divide con la classe
dominante della società che rappresenta e difende il sistema. Non si
riconosce nessuna particolarità di gruppo sociale. |
|
|
|
Si crede nei farmaci per difendere il
comportamento istituzionale, si giustificano i farmaci per garantire la
necessità della cura. "Il medico seda", dice Basaglia,
"attraverso i farmaci che somministra, la sua ansia di fronte a un
malato con cui non può rapportarsi, né trovare un linguaggio comune.
Compensa dunque in una nuova forma di violenza, la sua incapacità a
maneggiare una situazione che giudica ancora come incomprensibile,
continuando ad applicare l'ideologia medica dell'oggettivazione,
attraverso un perfezionismo della stessa." |
|
|
|
"Noi che siamo sopravvissuti
della sua morte sappiamo che non basta chiudere l'istituzione
manicomiale e porre fine alle vite bruciate fra le sue mura, silenzioso
olocausto consumato nel nome della scienza." (Galimberti). Il
potere che esercita la società stessa sul malato è che lo identifica
con la malattia decontestualizzata, per cosi togliersi la
responsabilità del modo in cui vive, pensa ed agisce . Basaglia dice,
che "l'oggettivazione risiede all’interno del rapporto fra malato
e medico, quindi all'interno del rapporto fra il malato e la società
che ne delega al medico la cura e la tutela." Qui vorrei
sottolineare, che la finalità della legge 180 era lo spostamento della
responsabilità professionale e istituzionale dalla tutela della
società della presunta o reale pericolosità della malattia, alla
tutela del malato nella società. |
|
|
|
La società in cui viviamo non è una
comunità che accoglie tutti i suoi membri per risolverne le difficoltà
insieme. Invece dell'integrazione e della responsabilità solidale
esistono esclusione e discriminazione. Regna il potere dello stato e delle suoi
istituzioni, della metafisica della religione, del individuo uno contro
l'altro, insomma il potere e la violenza. Basaglia dice, che "la
violenza e l'esclusione sono alla base di ogni rapporto che si instaura
nella nostra società. La società allarga l'appalto del potere ai
tecnici che lo gestiranno in suo nome e continueranno a
creare-attraverso forme nuove di violenza nuovi esclusi: la violenza
tecnica." |
|
|
|
Il manicomio è un potere che esclude
elementi critici della società, quelli che fanno pensare, perché
elementi sensibili e sofferenti. Basaglia dice, "che si scoprono,
tecnicamente, nuove forme di deviazione fino ad oggi considerate nella
norma, la quale è creata dalla scienza per difendersi." |
|
La scienza psichiatrica si costruisce
sull'oppressione e sulla presa di distanza della sofferenza
contestualizzata. Cosi si può rimanere nel vecchio sistema col potere
stabilito, capitalismo e violenza, con le mani pulite. Basaglia dice:
"Credo che uno delle principale possibilità di prevenzione della
malattia mentale sia la lotta contro la miseria."
"Tuttavia", dice Basaglia, "se la malattia è anche
legata, come nella maggior parte dei casi, a fattori socio-ambientali, a
livelli di resistenza all'urto di una società che non tiene conto dell’uomo
e delle sue esigenze, la soluzione di un così grave problema non può
che essere trovata in una impostazione socio-economica, tale da
consentire anche il graduale reinserimento di questi elementi che non
hanno retto allo sforzo, che non hanno sostenuto il gioco." |
|
|
|
Quando si confronta con la malattia
mentale, la società rifiuta di trovarsi di fronte a una persona e a una
malattia, la stigmatizza, considerandola un'eccezione alla regola, un
fallimento non-contestuale per difendere i suoi valori. |
|
Basaglia dice, "che la violenza
sulla quale una società repressiva e competitiva si fonda è quella con
la quale il disturbato mentale viene attaccato e velocemente scrollato
di dosso." |
|
|
|
Fermandosi sui concetti di malato e
sano, un metodo escludente, si perde di vista che la crisi è
fondamentalmente soggettiva e contestuale. La malattia non può essere
una spiegazione, giustificazione, per il contesto individuale o
collettivo. Questo significherebbe la caduta nel ruolo per tutti gli
essere umani di questa società. Diventa evidente che la funzione del
ruolo, e l'incapacità di uscirne, non permette più, e la distrugge, la
libertà individuale, sottomessa all'autorità del sistema. Basaglia
voleva proprio questo, "l'abolizione della distinzione normativa
sano/malato della psichiatria positivista, in quanto "a ciascuna
esperienza esistenziale va concesso l'opportunità di esprimersi."
Ma la società vuole continuare a vivere in quel "benessere"
senza "disturbi". Perciò sceglie e ha necessità di un
sistema che si fonda sull'opulenza e che rifiuta la "fame",
come il sistema capitalista-produttivista. Basaglia dice, "che la
società ha bisogno di aree di compenso, per concretare la necessità di
negare o di fissare in una oggettivazione una parte della propria
soggettività." |
|
|
|
Basaglia spiega, "che l'internato
dell'ospedale psichiatrico, perché è socio-economicamente
insignificante, è oggetto di una violenza originaria, la violenza del
nostro sistema sociale. Un uomo senza potere sociale, economico,
contrattuale su cui la società ha usato e continua ad usare la
violenza, riducendolo ad essere a-problematico e a-contraddittorio, per
mascherare la contraddittorietà della nostra società." |
|
|
|
"La follia è una condizione
umana. In noi la follia esiste ed e presente come lo è la ragione. Il
problema è che la società per dirsi civile dovrebbe accettare tanto la
ragione quanto la follia, invece incarica una scienza, la psichiatria di
tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla. Il manicomio ha
qui la sua ragion d'essere. Fa diventare razionale l'irrazionale",
dice Basaglia. |
|
|
|
|
|
Cos'era l'orrore che Basaglia vide
dentro il manicomio: cancelli, inferriate, porte e finestre sempre
chiuse, catene, lucchetti e serrature ovunque, segregazione dei letti di
contenzione, camicie di forza, bagno freddo, l'elettroshock, la
lobotomia. La legge Basaglia abolì gli ospedali psichiatrici, il
trattamento obbligatorio, e il concetto tradizionale di malattia
mentale, adesso considerata una malattia come tutte le altre. Nel
sistema d'intervento psichiatrico di Basaglia doveva essere la persona
malata a chiedere il ricovero per cosi avere libertà e dignità. |
|
Così con Basaglia si abolì quel
potere dell'istituzione psichiatrica e quello del discorso sulla follia
come quel potere che la società aveva di
fronte alla psiche. La liberazione dell'essere umano da un'autorità
istituzionale rappresenta l'antagonismo all'oppressione, al sistema
statale capitalista, e significa un'analisi dei poteri e del loro
linguaggio e la lotta per l'emancipazione. Un’etica sociale che vuole
liberare tutti, perché abolisce il potere, qui quello dell'assistenza
psichiatrica istituzionale tradizionale, che è reazionario e fonte di
regressione, malattia e miseria. "Per essere curata la follia deve
essere sottratta al mondo in cui essa ha origine", dice Basaglia. |
|
|
|
Liberare la società della violenza
del potere sottomettente aiuta a far ritornare l'individuo al contatto
con le sue radici. Per questo la liberazione dal potere istituzionale
potrà causare una nuova esperienza di libertà per tutti. Questa nuova
situazione sociale potrà rappresentare un avvicinamento alla
prevenzione della malattia mentale, perché pone fine alla miseria
sociale e all’egoismo
che creava l'immagine della società senza contraddizioni. Questo aiuterà pure a smascherare il volto del
potere, che porterà ad una maggiore coscienza da parte di tutti della
realtà sociale. |
|
Invece delle strutture permanenti
secondo Basaglia ci dovevano essere cure sul "territorio".
Questo per avere un migliore contatto del malato con la realtà e per
arrivare ad una maggiore integrazione di questi da parte della società.
Per restituirle il tema della follia. Basaglia si domanda, "cosa
accadrebbe se ancora una volta l'internamento fosse consentito da una
legge che autorizzasse la sospensione dei dritti della persona in nome
della cura, l'allontanamento dalla vita in nome della protezione di chi?
Dell’ordine pubblico?" |
|
|
|
"Le malattie mentali sono un
problema politico perché sociale" dice Basaglia. "... Se
dunque la situazione asilare ha rivelato l'antiterapeuticità
sostanziale delle sue strutture, una trasformazione che non sia
accompagnata da un travaglio interno che la metta in discussione dalla
base, risulterebbe del tutto superficiale ed apparente. Ciò che si è
rivelato antiterapeutico e distruttivo nelle istituzione psichiatriche
non è una tecnica particolare o un singolo strumento, ma l'intera
organizzazione ospedaliera che, tesa com'è all’efficienza del
sistema, ha inevitabilmente oggettivato ai suoi occhi il malato, che
doveva essere l'unica finalità della sua esistenza. Non potendo più
escludere come problema il malato mentale, si tenta infatti ora di
integrarlo in questa stessa società, con tutte le paure e pregiudizi
nei sui confronti che l'hanno sempre caratterizzata, mediante un sistema
di istituzioni che in qualche modo la preservi dalla diversità che il
malato mentale continua a rappresentare. Ora ci sono due strade da
seguire: o decidiamo di guardarlo in faccia senza più tentare di
proiettare in lui il male da cui non vogliamo essere toccati,
considerandolo un problema che deve fare parte della nostra realtà e
quindi non si può eludere, o affrettiamoci, come la nostra società sta
già tentando di fare, a sedare la nostra ansia, erigendo un nuovo
diaframma che aumenti la distanza, appena colmata, fra noi e fra loro, e
costruiamo subito un bellissimo ospedale". |
|
"Poi, nel primo caso",
spiega Basaglia, " il problema non può però mantenersi entro i
limiti ristretti di una "scienza" quale la psichiatria, che
non conosce l'oggetto della sua ricerca; ma diventa un problema generale
che riveste un carattere più specificamente politico, implicando il
tipo di rapporto che la società attuale vuole o non vuole impostare con
una parte dei suoi membri ...." L'operazione di Basaglia era di
chiudere l'istituzione manicomiale e di introdurre il ricovero dentro
gli ospedali generali per integrare la persona malata nella vita da dove
proviene e alla quale appartiene. |
|
|
|
Vedendo nella malattia mentale una
malattia del cervello, la psichiatria organicista attacca la legge 180,
e la destra esclude che sia il sistema politico-economico-sociale a
creare le vittime manicomiali. |
|
La destra vuole il trattamento
sanitario obbligatorio e strutture residenziali permanenti. |
|
|
|
Basaglia dice, che, "per
lottare contro i risultati di una scienza ideologica, bisogna anche
lottare per cambiare il sistema, nel tentativo di riconoscersi
ideologicamente come una società senza contraddizioni. Per poter
ricostruire gradualmente il volto del malato, cosi come doveva essere
prima che la società, con i suoi numerosi atti di esclusione e
l'istituto da essa inventata, agissero su di lui con la loro forza
negativa." |
|
|
|
|
|
Basaglia dice, che, "la
costituzione di un complesso ospedaliero retto comunitariamente e basato
su premesse che tendano alla distruzione del principio dì autorità, ci
pone però in una situazione che va slittando dal piano di realtà sul
quale vive la società attuale. È per questo che un tale stato di
tensione non può che essere mantenuto da una radicale presa di
posizione da parte dello psichiatra, che vada oltre il suo ruolo e si
concretizzi in un'azione di smantellamento della gerarchia di valori su
cui si fonda la psichiatria tradizionale. Ciò ci richiede, tuttavia, di
uscire dai nostri ruoli per rischiare di persona, per tentare l'abbozzo
di qualcosa che, seppure già avrà in sé i germi dei futuri errori, ci
aiuti, per il momento a rompere questa situazione cristallizzata, senza
aspettare che siano solo le leggi a sancire le nostre azioni...(Le
regole istituzionali sono stabilite per distruggere ciò che resta di
personale nel singolo a salvaguardia del buon andamento e della
organizzazione generale.) La comunità terapeutica, cosi intesa, non
può che essere in opposizione alla realtà sociale in cui si vive
perché, basata com'è su dei presupposti che tendono a distruggere il
principio di autorità nel tentativo di programmare una condizione
comunitariamente terapeutica, essa si pone in netta antitesi con i
principi informatori di una società, ormai identificata con le regole
che, al di là di ogni possibile intervento individuale, la convogliano
in un ritmo di vita anonimo, impersonale, conformista." |
"La comunità terapeutica:
malati, infermieri, medici sono uniti in un impegno totale dove le
contraddizioni della realtà rappresentano l'humus dal quale scaturisce
l'azione terapeutica reciproca, rompendo con una situazione di
cristallizzazione dei ruoli. Vivere dialetticamente le
contraddizioni del reale è dunque l'aspetto terapeutico del nostro
lavoro. Nella comunità terapeutica si discutono le prevaricazioni degli
uni sugli altri e la tecnica del capo espiatorio dialetticamente. Poi
inclusa nella dialettica c’è l'alternativa. Quando il malato non ha
alternative, si trova imprigionato nel terreno psichiatrico e nel mondo
esterno di cui non riusciva ad affrontare dialetticamente le
contraddizioni e fuggiva nella produzione psicotica, nel delirio, dove
non c'è ne contraddizione, ne dialettica." (Basaglia) |
|
|
|
"Il malato mentale è un escluso
che, in una società come l'attuale, non potrà mai opporsi a chi lo
esclude, perché ogni suo atto è ormai circoscritto e definito dalla
malattia. Solo la psichiatria, nel suo duplice ruolo medico e sociale,
può essere in grado di far conoscere al malato cos'è la malattia e che
cosa la società gli ha fatto, escludendolo da sé," dice Basaglia. |
|
|
|
Basaglia cercava di superare quell’atteggiamento
che giustifica l'insuccesso dell'incontro con l'altro con
l'incomprensibilità di quest'ultimo che "in quanto tale è da
relegare nella schiera degli esclusi da parte dalla psichiatria."
(Basaglia) |
|
Basaglia combatte la concezione di
malato psichiatrico pericoloso per la società, facendo rientrare la
psichiatria nell'ambito della medicina. Il fatto che la società
considera il paziente psichiatrico pericoloso Basaglia lo chiama
"una crisi di idee che coincide con una cultura che si sta
riaffermando nel nostro paese (discriminazione dei immigrati,
emarginati)." |
|
|
|
La scissione della psiche della gente
passa per la scienza, il potere oggettivante, escludente
ideologicamente, per il potere tecnico medico. Tramite l'autorizzazione
della scienza a risolvere il tema della follia nella vita mentale delle
persone "sane", il manicomio ha la sua ragion d'essere.
Basaglia dice, che è "la dinamica del potere come fonte di
regressione, malattia, esclusione e istituzionalizzazione a tutti i
livelli." |
|
|
|
In Asylum, libro di Ervin Goffman
tradotto, da Franco Basaglia nel 68 presso Einaudi, Goffman spiega che
per il sé del paziente la sua permanenza sotto le condizioni di vita
nel manicomio ha conseguenze disastrose. |
|
Il malato mentale nel manicomio non ha
nessuna possibilità di individuare una parte di se stesso dal contesto
dell’agire dell'istituzione su di lui. Manca un'area che gli permette
di mantenere una certa stabilità psichica individuale, che non sia
sacrificata dall'istituzione, che mette tutto l’essere del paziente
sotto condizioni di trattamento autoritario assoluto. Per questo per i
pazienti mentali le espressioni di distanza dal sé possono essere di
tipo psicotico. |
|
Goffman sottolinea che "nell’ospedale
psichiatrico lo staff "divide con i poliziotti lo strano compito
professionale di educare e moralizzare gli adulti. Questa necessità di
sottomettersi a queste lezioni è una delle conseguenze del fatto di
aver commesso atti contro l'ordine sociale della comunità." Per
poter reggere la sua situazione di internato nel manicomio, o per poter
andarsene da li, il malato deve accettare il ruolo dello staff. |
|
Secondo Goffman, "gli ospedali
psichiatrici esistono perché c'e un mercato di lavoro, si non ci
fossero più questi ospedali psichiatrici, polizia, giudici e parenti ne
richiederebbero nuovi." |
|
La giustificazione per l'esistenza
dell’ospedale psichiatrico secondo Goffman è la presenza del paziente
nel ospedale: "la testimonianza che è malato." Si deve
scoprire un crimine che si adatta alla punizione, e ricostruire la
natura dell'internato per adattarla al crimine." |
|
Gofmann dice, "che le mura dell’istituto
agiscono come un prisma che ingrandisce e colpevolizza, e che per questa
ragione l'ospedale psichiatrico è il posto meno indicato perché il
tecnico vi possa fare le sue osservazioni." Le
condizioni orribili di vita del malato mentale all’interno di queste
mura sono la ragione per comportamenti di disperazione, di tristezza, di
protesta. |
|
Basaglia spiega, che "Goffman è
riuscito a trovare, al di la di ogni classificazione e codificazione, il
significato razionale e umano di malati mentali che vengono distrutti
all’interno dell’istituzione deputata alla gestione dell’irrazionale
e del disumano. Lui distrugge l'immagine del malato che era pensato per
avere una malattia che distrugge e disumanizza. Goffman dice, spiega
Basaglia, che l'istituzione psichiatrica tradizionale non è altro che
un’istituzione carceraria, deputata a gestire il disturbo sociale.
L'ospedale psichiatrico si dedica poi alla gestione dell'esclusione, la
custodia. Del resto, è stata la psichiatria che, nel definire il malato
come irrecuperabile e incomprensibile, ha proposto un'unica possibilità
di approccio: quello di natura oggettuale (antiterapeutica per essenza)
in una relazione dove il secondo polo del rapporto non esiste, se non
come oggetto da inglobare e incorporare nel sistema generale." |
|
|
|
Il carattere politico dell’istituzione
psichiatrica, che non si fonda sulla neutralità scientifica, non può
servire come modello medico, dice Goffman. La psichiatria tradizionale
rappresenta i valori di un gruppo o di una persona dominante. |
|
Goffman identifica la relazione
psichiatra-malato con un rapporto di potere e ci spiega la
responsabilità di quel rapporto per la graduale distruzione del se del
malato. |
|
"L'istituzione deve la sua
sopravivenza alla spoliazione di ogni ruolo umano del internato in essa
incorporato", dice Goffman. In questo contesto l'oggettivazione del
paziente è fonte essa stessa di regressione e malattia.
"L'istituzione fabbrica un malato a sua immagine". Lo
psichiatra ne gestisce le sorti. |
|
Goffman definisce la condizione del
rapporto che si stabilisce con l'internato "un rapporto che unisce
ciò che esclude all’escluso, e che spieghi la funzionalità e il
significato dell'istituzione deputata alla gestione dell'esclusione. In
questo senso il problema si apre sulla funzionalità sociale delle
istituzioni totali, deputate a gestire le nostre contraddizioni più
palesi." |
|
|
|
Franco Basaglia spiega come
"nella società capitalistico-produttivistica la norma è la
salute, la giovinezza, la produzione e che questa società si fonda
sull'ideologia del benessere e dell'abbondanza per coprire la fame.
Questa fame non può manifestarsi brutalmente per ciò che è, ma deve
venir velata e schermata attraverso le ideologie che la definiranno di
volta in volta come vizio, malattia, razza, colpa. Una società del
genere non può programmare sufficienti misure preventive o
assistenziali. Si salva ciò che può essere facilmente recuperato; il
resto viene negato attraverso l'ideologia dell'irrecuperabilità,
dell'incomprensibilità, della natura umana, su cui si costruisce il
castello del pregiudizio. La malattia, la vecchiaia, l'infortunio sono
accidenti all'interno di una realtà che non vuole e non può premunirsi
e preoccuparsi delle proprie contraddizioni. Le
contraddizioni vengono sancite come un dato. Continua Basaglia "Da
qui parte l'ideologia del bene. Il resto è il risultato di un
fallimento che troverà spiegazioni scientifiche e filosofiche, in una
scienza e una filosofia che maschereranno il loro legame con la classe
dominante sotto la mistificazione della neutralità tecnica. I valori
sono fissati una volta per tutte dalla classe dominante e da una scienza
che la difende, ma solo chi non ha cade nelle sanzioni studiate per
dominarlo e indebolirlo." |
|
Basaglia esprime che "lo
smascheramento di ciò che è stata l'azione istituzionale degli
psichiatri li rivelerà ai loro stessi occhi, come semplici strumenti di
controllo sociale, in balia del sistema che li determina, o sanciranno,
ancora una volta, nella loro qualità di delegati del potere, un
esclusione sociale sotto l'etichetta della malattia? In questi
condizioni, è possibile parlare di scienza, se non si chiarisce prima
che cos'è la politica di questa scienza?" |
|
Secondo Basaglia la sofferenza del
malato è quella di dover vivere in modo "a-problematico"
"e a-dialettico", i poteri e la crudeltà della realtà
essendo spesso insopportabili. |
|
|
|
Basaglia spiega, parlando della
comunità terapeutica, che è "il tipo di rapporto che viene ad
instaurarsi all'interno di questa comunità che la renderà terapeutica,
nella misura in cui riuscirà a mettere a fuoco le dinamiche di violenza
e di esclusione presenti nell'istituto, cosi come nell'intera società,
creando i presupposti per una graduale presa di coscienza di questa
violenza e di questa esclusione." |
|
|
|
|
|
Alcune informazioni biografiche: |
|
|
|
Franco Basaglia nasce a Venezia, l’11
marzo 1924 e muore il 29 agosto nel 1980 per un tumore al cervello. |
|
Dopo aver conseguito la maturità
classica si iscrive alla facoltà di medicina dell’università di
Padova. In queste periodo comincia a leggere Husserl, Heidegger, Sartre,
Merleau-Ponty. |
|
Se laurea nel 1949. Nel 1953 si
specializzò in malattie nervose e mentali. |
|
Nel 1961 va a Gorizia dove prende la
Direzione dell’ospedale psichiatrico. Li vede il manicomio da dentro,
spaventandosi per quello che vedeva. |
|
Basaglia si avvicina culturalmente a
Jaspers, Minkowski, Biswanger, correnti psichiatriche di ispirazione
fenomenologica ed esistenziale. I suoi riferimenti teoretici furono
Sartre, soprattutto in quanto riguarda il concetto di libertà, Foucault
e Goffmann, per la critica all'istituzione psichiatrica. |
|
Nel manicomio di Gorizia erano allora
ricoverati 650 pazienti. Con la direzione Basaglia comincia in questa
istituzione una vera e propria rivoluzione: elimina tutti i tipi di
contenzione fisica e le terapie di elettroshock, aprendo le inferriate e
i cancelli. |
|
Nel 1967 Basaglia cura il volume
"Cos'è la psichiatria?", nel 1968 pubblica
"L'istituzione negata. Rapporto da un ospedale psichiatrico." |
|
Nell’ agosto di 1971 diventa
direttore dal manicomio di Trieste, il "San Giovanni",
dov'erano presenti quasi milleduecento malati. Ma questa volta Basaglia
sente il bisogno di andare oltre la trasformazione della vita all'interno dell’ospedale psichiatrico: il manicomio per lui va chiuso
ed al suo posto va costruita una rete di servizi esterni. |
|
Nel 1973 Trieste venne designata
"zona pilota" per l'Italia nella ricerca dell’ O.M.S. sui
servici di salute mentale. Nello stesso anno Basaglia fonda il movimento
"Psichiatria Democratica". |
|
Nel gennaio 1977, in una
affollatissima conferenza stampa, Franco Basaglia e Michele Zanetti,
presidente della provincia di Trieste, annunciano la chiusura dell’Ospedale
San Giovanni entro l'anno. |
|
|
|
L'anno successivo, il 13 maggio 1978
viene approvata in Parlamento la legge 180 di riforma psichiatrica.
Questo significa la chiusura del manicomio, ma non risolve la grande
preoccupazione di Basaglia per quel che riguarda i rapporti sociali e la
violenza del sistema. |
|
Lui voleva un cambio del sistema, un
sommovimento della società per liberare l'essere umano delle
sovrastrutture di potere, violenza e esclusione, dalle restrizioni e dai
limiti del potere di quel sistema. |
|
|
|
|
|
Bibliografia essenziale: |
|
|
|
"L’istituzione negata" –
a cura di Franco Basaglia, Einaudi , Torino, 1968 |
|
"Scritti" vol. 1: 1953-1968:
Dalla psichiatria fenomenologica all'esperienza di Gorizia - F.
Basaglia, Einaudi, Torino, 1981 |
|
"Scritti" vol. 2: 1968-1980.
Dall'apertura del manicomio alla nuova legge sull'Assistenza
psichiatrica – F. Basaglia, Einaudi, Torino |
|
"Conferenze Brasiliane" –
F. Basaglia, Raffaello Cortina, Milano, 2000 |
|
"Che cos’e la
psichiatria?" – F. Basaglia, Baldini Castaldi Dalai, 1997 |
|
"La maggioranza deviante"
– F. Basaglia – F. Ongaro, Einaudi, Torino |
|
"La violenza" – F.
Basaglia – F. Fornari, Vallecchi. Forense, 1978 |
|
"Asylums" – Erwin Goffman,
Einaudi, Torino, 1974 |
|
| |